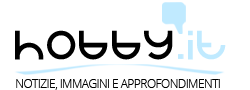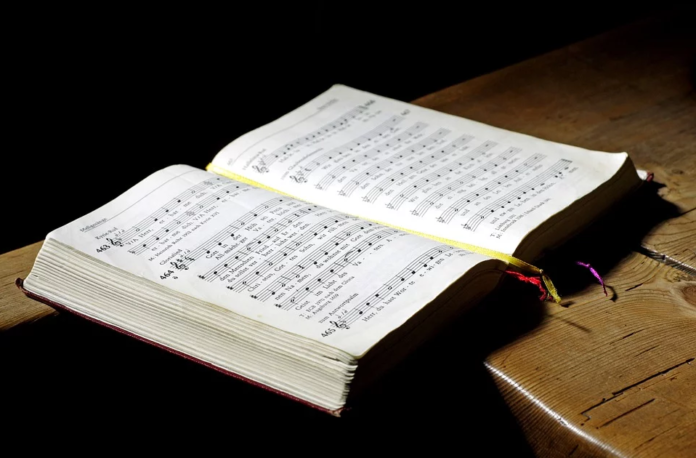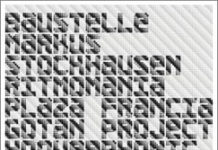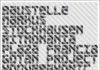Spaventa, dispera, impone, costringe, eccita la curiosità, sorprende, incuriosisce, ordina, determina, esige. Parliamo naturalmente della teoria musicale per imparare a suonare uno strumento musicale. Per progredire bene nelle esecuzioni, devi padroneggiare la diteggiatura, decifrare e leggere le note musicali, ma questo apprendimento richiede molto tempo e pratica. Prima di tutto, bisogna definire cos’è la teoria musicale e capire come sfruttare la sua conoscenza per l’uso di uno strumento musicale. E qui diventa necessario lo studio del solfeggio.
La parola solfeggio è usata in un duplice senso: in un primo luogo, designa tutte le conoscenze necessarie per leggere e produrre suoni di segni musicali. In un secondo luogo, ciò permette l’acquisizione di competenze specializzate destinate all’acquisizione di questa conoscenza. La teoria musicale stimola l’orecchio musicale, ascoltando e leggendo le note musicali. Il mondo della musica utilizza otto note: do, re, mi, fa, sol, la, si e do (dall’ottava superiore).

L’elemento essenziale
da conoscere quando si vuole iniziare a solfeggiare (e poi apprendere
uno strumento) è il pentagramma
vuoto. Esso è composto da cinque linee orizzontali parallele
su cui scriviamo (e leggiamo) la musica, in modo che le note
musicali, le pause e gli altri simboli musicali (la chiave di violino
o la chiave di basso, le indicazioni ritmiche, le battute, le
sfumature, le indicazioni del tempo). Il rigo è diviso in misure
usando le battute. Ciò semplifica la lettura e la struttura della
scrittura musicale. Nel complesso le cinque righe formano quelle che
in gergo si chiamano “cinque righi e quattro spazi”, ognuno di
questi nove ospiterà la sua nota musicale di riferimento.
A
questo punto sarà necessario dunque, una volta conosciuto l’ospite,
apprendere le note musicali. La teoria musicale fornisce una
spiegazione sull’origine dei nomi delle note, sulla loro scrittura
(la testa, il gambo, il gancio) e la loro posizione sulle linee di un
rigo (comprese le linee aggiuntive). È anche importante conoscere il
nome e l’ordine delle note. Possiamo osservare movimenti congiunti o
disgiunti, ascendenti o discendenti di note. Le figure della nota (il
giro, il bianco, il nero) sono usate per indicare la durata della
nota da suonare. Troverai una tabella completa di queste figure con
per ognuna il valore e alcune equivalenze. Fare attenzione anche ai
segni di enfasi che sono nient’altro che segni di
accentuazione i quali arricchiscono la scrittura delle note (il
trattino, il punto, l’accento) e in generale la scrittura musicale
(il punto più alto, ad esempio). Troviamo questi segni molto spesso
nei solfeggi.
Dopo
queste nozionistiche di base ti senti pronto a investire il tuo
tempo, la tua pazienza e la tua energia nel solfeggio?
Per essere
un eccellente musicista bisogna avere predisposizione, senso della
disciplina e abnegazione; questo comporterà la necessità di dover
ripetere meccanicamente una serie di azioni quotidianamente per
sperare di avanzare nel proprio livello di preparazione.
Sarà
dunque necessario ripetere gli esercizi di teoria musicale
regolarmente e per brevi periodi (da 5 a 20 minuti al giorno);
prestare piena attenzione alla lettura delle note, riducendo la
velocità di lettura. Non si tratta di impressionare nessuno ma di
conservare ciò che leggiamo. Saltare i passaggi potrebbe
incoraggiare cattive abitudini ed errori. Quindi imparare ad usare un
metronomo, accelerare gradualmente la velocità di apprendimento
delle note aumentando le ottave e la difficoltà. Iniziare sempre con
partiture semplici, inoltre dobbiamo scegliere gli spartiti della
musica che ci piace, dopo tutto la musica è anche questo: suscitare
il piacere di imparare. Lavora sulle lacune. Avanzare passo dopo
passo, prendendo le note che risultano più ostiche per comprenderle
e assimilarle meglio.